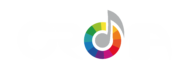Che cos’è l’arte? Questa domanda risuona nell’uomo da quando ha preso consapevolezza di sé, al pari delle domande esistenziali sul senso della vita o sull’esistenza di Dio. Tante sono state le risposte che si sono provate a dare, più o meno complesse, ma ancora oggi non se ne è trovata una univoca: quello che è certo è che l’uomo non può smettere di fare arte; di dipingere, di scolpire, di danzare, di recitare, di fare canzoni e musica.
A proposito di quest’ultima, si è concluso da pochissimo il 71° Festival di Sanremo; un festival sicuramente insolito e unico date le circostanze in cui si è svolto e le modalità in cui è stato trasmesso. Forse è passato in sordina, come tante altre volte in questi anni, ma è incredibile come al Festival di Sanremo trionfi sempre e comunque… il dolore. È stata cantata la lontananza, la fine di rapporti, l’indignazione, la rabbia, la ribellione; e quest’ultima, guarda un po’, è stata la vincitrice, sbattuta in faccia ai telespettatori dalla canzone dei Maneskin. Non siamo qui per discutere se sia stata una vittoria reale, comprata, guidata dalle Major discografiche o dalle lobbies dei talent, ma come sempre cerchiamo di trarre un insegnamento da ciò che accade.
È significativo il fatto che, in una realtà dominata da un profondo senso di frustrazione di fronte alla situazione complessa e faticosa che stiamo vivendo, a vincere la trasmissione più popolare d’Italia non sia la struggente dolcezza di un amore cantata da Ermal Meta, né la semplicità di una canzone Pop unita alla potenza social del duetto Michielin – Fedez, ma la rabbia e l’aggressività del rock duro dei Maneskin. La pandemia era presente non solo nei palloncini che affollavano le sedie dell’Ariston o nell’esibizione pre-registrata di Irama, ma anche nei testi delle canzoni. Mi piace pensare che la vittoria dei Maneskin sia il sentimento di riscatto e ribellione, manifestato non con i rave-party per le strade, ma attraverso la musica. Una ribellione sana dunque, e in quanto tale anche positiva. Sapete qual è la cosa meravigliosa? È che non abbiamo pensato a tutto ciò mentre eravamo lì davanti alla televisione. Abbiamo ascoltato le canzoni, abbiamo valutato, abbiamo riso e commentato i cantanti in gara; tutta quella rabbia, quella ribellione, quel dolore cantato ci è passato sotto il naso. Non è colpa della nostra disattenzione o sordità emotiva, ma è grazie a una magia che è propria solo dell’arte. Il dolore cantato, danzato, dipinto, scolpito si trasforma. In una canzone diventa qualcosa che possiamo ascoltare anche con la leggerezza di un bambino, che possiamo cantare con i brividi lungo la schiena, che possiamo fare nostro o che possiamo anche ignorare.
Tutto ciò perché l’arte, muovendo le corde dell’empatia, veste il dolore, lo modifica senza snaturarlo e gli permette di arrivare a noi, in un modo o nell’altro. Ed è interessante analizzare proprio come tutto ciò sia arrivato a noi: attraverso quali sonorità, quali voci, quali immagini. Tutto possiamo dire di questo Sanremo, ma non certo che abbia brillato di performance vocali e ugole cristalline. Abbiamo però visto una rappresentazione piuttosto fedele del panorama musicale attuale, dove la musica non è più il regno della qualità esecutiva e della performance canora, ma un luogo in cui la canzone vive di imperfezioni anche volutamente accentuate e buttate lì, di testi in cui prevalgono immagini quasi di natura morta che comprendono tostapane, pasta e ibuprofene, o di voci alterate, elettrificate dall’autotune, di pronunce distorte. La musica oggi cerca lo strappo, il gridare cose, il verismo estremo, il buttare in faccia emozioni e pensieri così, quasi come capita. In realtà dietro a qualcosa che apparentemente sembra sciatto e raffazzonato c’è una seria consapevolezza di ciò che si sta facendo, c’è la volontà di dare uno scossone alla tradizione, al mondo imbellettato della musica più tradizionale. Ma in fondo, nel corso dei secoli, non è sempre stato così? Di tanto in tanto arrivava qualche pittore, qualche musicista, qualche scultore che con il suo linguaggio provocava, scandalizzava, innovava. Che sia arrivato di nuovo uno di quei momenti? Possiamo vederci questo nel sangue finto di Achille Lauro. Alcuni direbbero di no, che è troppo, che adesso basta, e forse effettivamente dei canoni artistici devono esistere, se non altro per evitare che la rottura diventi solo una scusa per essere scadenti. Ma dobbiamo stare attenti a non pensare che l’essere fedeli a questi canoni ci faccia diventare sordi ai messaggi che ci arrivano. Leggete queste parole: “È giunto il nostro momento. La nostra stessa fine in questa strana fiaba. La più grande storia raccontata mai. Maschere dissimili recitano per il compimento della stessa grande opera. Tragedia e commedia. Essenza ed esistenza. Intesa e incomprensione. Elementi di un’orchestra troppo grande per essere compresa da comuni mortali. È giunto il nostro momento. Colpevoli, innocenti. Attori, uditori. Santi, peccatori. Tutti insieme sulla stessa strada di stelle. Di fronte alle porte del Paradiso. Tutti con la stessa carne debole. La stessa rosa che ci trafigge il petto. Insieme, inginocchiati davanti al sipario della vita. E così sia. Dio benedica Solo Noi. Esseri Umani”. Sono le parole del monologo di Achille Lauro fatto nella serata della finale, nelle quali è presente un significato profondo per il momento che stiamo vivendo e un messaggio da cogliere, ma forse ce lo siamo persi, tutti presi a indignarci per le rose infilate nel petto e per il sangue finto. Certo, è troppo, e forse irrispettoso per alcune sensibilità, ma il nostro senso critico serve a questo: a comprendere e accogliere i messaggi che ci arrivano, facendo nostro ciò che è buono e positivo e mettendo da parte ciò che per noi è troppo, irrispettoso o semplicemente non ci piace. Sarò sincero, io per primo ho fatto fatica a comprendere e apprezzare canzoni in cui la sbavatura canora non è solo contemplata ma addirittura accentuata volutamente, in cui la musica da sola non basta più: ha bisogno di provocazione, di immagine che tiene desta l’attenzione e di molto altro. Potremmo dire che questo è un peccato, è un bistrattare la musica in quanto tale perché la musica va prima di tutto ascoltata, ma forse ancor prima va ascoltato ciò che un cantante vuole dire indipendentemente dal linguaggio che utilizza.
Abbiamo quindi visto dell’arte a Sanremo quest’anno? Per me sì, in forme che possono incontrare o meno i nostri gusti, perché comunque abbiamo ascoltato musica, un’orchestra magistrale, dei componimenti musicali veramente ben fatti e degli artisti che hanno raccontato di noi e di ciò che tutti stiamo vivendo. Prima quindi di dire che i cantanti stonano, che l’autotune è la rovina della musica, che il rap è solo rumore, forse conviene ascoltare con le orecchie e con la mente e poi, farsi un’opinione squisitamente personale. Chi scrive canzoni ha in mano una grande libertà di espressione che, a differenza di quella spesso reclamata nel mondo di oggi, non nega, non offende gratuitamente, non insulta, non sa di sapere, ma semplicemente è lì a farsi guardare e ascoltare, senza replicare. Una cosa però è importante, la musica è e rimane soprattutto musica, e quindi una volta che il carrozzone di Sanremo è passato, diamole lo stesso l’occasione di essere semplicemente se stessa. Sediamoci, cerchiamo una playlist di queste canzoni e – finalmente senza maschere, luci, immagini e costumi – poniamoci in ascolto.
Testo di Mattia Tagliani
Per saperne di più sui giovani e la musica contemporanea, leggi anche L’arte (terapeutica) di scrivere canzoni