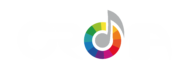Eccoci qui, emersi finalmente dalle profondità del lockdown con la testa fuori dalla superficie dell’acqua, a respirare un po’ di aria; il peggio è finalmente passato, o almeno tutti speriamo sia così. Ora però ci guardiamo intorno e la terra ferma che credevamo a pochi metri da noi rimane tanto lontana, ancora sbiadita dalla nebbia dell’incertezza. Cosa fare dunque? ci troviamo di fronte ad una scelta: lasciarci trasportare dalla corrente, sperando che prima o poi ci porti verso la calda e asciutta superficie terrestre, oppure iniziare a nuotare, magari pensando di dotarci di branchie e pinne in modo da rendere ospitale un mondo che non è proprio uguale al nostro e che però potrebbe diventare, se non una nuova normalità, una normalità alternativa. Questo mare di contatti ridotti al minimo, filtrati dai guanti, dalle distanze e dalle mascherine è un universo parallelo, che ai nostri occhi pare ostile e inospitale: quelle relazioni umane fatte di corpi, pelle e parole, spesso accantonate per fare spazio a quelle fittizie introdotte dalle cosiddette “nuove tecnologie”, ora ci paiono dotate di una freddezza che un po’ ci spaventa.
Anche il mondo delle terapie deve fare i conti con una realtà che le ha spogliate di quasi tutto: oggetti, materiali, strumenti sono tutti centellinati, se non eliminati, per ridurre al minimo i rischi di contagio. Come può un musicoterapeuta, ad esempio, dare a un bambino la possibilità di scegliere e sperimentare diversi tipi di strumenti musicali se non con macchinose regole di sanificazione? Come può un artista terapista permettere ad un paziente di sporcarsi le mani, di avere un contatto diretto con la materia, con il colore senza dover rendere quel materiale inutilizzabile per altri pazienti? In questo difficile scenario spesso la scelta è eliminare strumenti musicali, colori e tempere. La stanza di musicoterapia e di arte terapeutica, da luogo sognante e colorato, si trasforma in un asettico e spoglio ambulatorio medico. Cosa fare dunque?
Forse una delle soluzioni sta in quelle famigerate e già citate “nuove tecnologie” che, se ci pensiamo, durante gli scorsi mesi, si sono trasformate da gelide nemiche del contatto umano a fidate alleate che hanno permesso di mantenere saldi i rapporti tra amici, fidanzati e parenti. Un tablet può essere qualsiasi cosa, proprio perché, in sé e per sé, non è nulla se non una lastra di vetro. Può diventare una tastiera musicale, può rivelarsi foglio bianco su cui sperimentare colori e linee; il cellulare del terapeuta può riprodurre suoni, video e immagini e può diventare strumento indispensabile durante la terapia…indispensabile come lo è stato per alcune famiglie che, attraverso la chiamata di un’infermiera, hanno potuto dare un ultimo saluto al papà, alla mamma o al nonno. Forse è proprio vero quello che abbiamo sempre proferito senza mai provarlo realmente sulla nostra pelle: gli aggeggi infernali che inventiamo, proprio perché prodotti dall’uomo, sono strumenti nelle nostre mani, e se utilizzati con sapienza, bontà e intelligenza possono essere il mezzo per crescere, per quel fare quel bene che oggi, senza ciò che avevamo prima, ci sembra così difficile da perseguire. La flessibilità dei nuovi strumenti, pur eliminando la componente corporea, fondamentale nelle arti terapie, con la rispettiva versatilità apre a nuove prospettive che, mi permetto di dirlo, i metodi tradizionali di terapia non hanno. Con una app è possibile ascoltare una canzone, oppure registrarla e riascoltarsi, fare foto e modificarle, lavorando sulla percezione di sé, sulle capacità attentive e percettive. È possibile creare musica e disegni, raccontarsi attraverso un mezzo che, ormai noi e i nostri figli non possiamo ignorare ed accantonare, ma comprendere e declinare alle nostre esigenze. Perché dopo tutto, il Covid-19 non è riuscito ad eliminare gli elementi principali di una terapia: il terapeuta e il paziente. Tutto ciò che è all’interno della relazione terapeutica è strumento, mezzo per raggiungere il bene della persona. Un muro colorato da indicare diventa uno strumento per lavorare sull’oppositività di un bambino alle prime uscite dopo quattro mesi di chiusura in casa.
La nostra più grande speranza è che arriverà il giorno in cui le nostre stanze si riempiranno di nuovo di maracas, tamburi, tempere, fogli e creta, ma in quel giorno, se saremo riusciti a metterci in gioco come terapeuti attenti alle nostre risorse più che alle nostre mancanze, avremo a disposizione un arsenale di strumenti terapeutici ancora più vasto, in cui analogico e digitale concorrono allo stesso obiettivo. Ecco la resilienza, quella vera, la capacità di guardare ai propri strumenti e di fare i conti con quelli, indipendentemente da ciò che manca e che non abbiamo. Ecco che forse quelle “branchie” e quelle “pinne”, che ci saranno cresciute dopo giorni di navigazione in questo nuovo mare, non le butteremo una volta tornati sulla terra ferma, ma le terremo con noi per essere più pronti, per essere più forti.
Testo di Mattia Tagliani
Immergiti nei contenuti di teoria e pratica
Per saperne di più guarda (o ascolta) la prima puntata di RGB, il podcast di Croma